Con l’avvento di Michael Manley alla guida del gruppo Fiat-Chrysler, si può dire che cada anche l’ultimo velo sull’italianità del gruppo Fiat. Ed è tempo di una riflessione complessiva su questo punto, una riflessione troppo a lungo rimandata. E che va inquadrata bene, cioè senza dimenticare due fondamentali premesse. La prima è che solo con Marchionne la Fiat ha potuto evitare di portare i libri in tribunale. La seconda è che unendo il salvataggio di Fiat a quello di Chrysler l’internazionalizzazione del gruppo è avvenuta nel 2009-2012, e credere che l’origine abruzzese della famiglia Marchionne fosse una storia che continuava invece di una che evolveva radicalmente è stato un terribile abbaglio di molti.
La radice italiana di Fiat e quel che Fiat deve all’Italia non è un’opinione, sta scritta nei più seri libri dedicati alla lunga parabola del gruppo da parte di storici come Valerio Castronovo o Giuseppe Berta. Dalle commesse di guerra nel primo e nel secondo conflitto mondiale, alle ingenti risorse finanziarie destinate al gruppo dalle banche pubbliche dopo la nascita dell’Iri sotto il fascismo.
Fino alla tutela assoluta perché in Italia non entrasse mai un produttore concorrente estero – ricordare sempre a questo proposito il no della politica all’interesse della Ford per fare di Alfa Romeo il marchio sportivo della casa americana: un’Alfa che allo scoppiare della sua crisi nel 1993 produceva ancora 200mila vetture rispetto alle 183 mila allora della Bmw; poi il vano tentativo della politica di tradurla in un braccio operativo dell’assistenzialismo nel Mezzogiorno col penoso fallimento dell’esperimento Alfa-Nissan, e infine la vendita del Quadrifoglio a condizioni di favore alla Fiat negli anni Ottanta.
Più una miriade di incentivi e finanziamenti pubblici, enormi risorse pubbliche per gestirne i cassintegrati nelle successive ristrutturazioni, giù giù fino agli incentivi all’acquisto di auto interrottesi poi negli anni Duemila. In un suo libro, Massimo Mucchetti ha calcolato, sommando le diverse cifre di una lunghissima storia dell’intero Novecento, che si si arrivasse a una cifra monstre nell’ordine di circa 200mila miliardi di lire. Dei quali diecimila miliardi nei soli anni Novanta. Cominciando da 6.059 di contributi in conto capitale e in conto interessi come incentivi agli investimenti nel Mezzogiorno solo nel post 1988. L’esenzione decennale dalle imposte sul reddito per tutte le società Fiat che operavano nel Sud. Altri 328 miliardi dalla legge 488 negli anni 1996-2000. Ben 1228 miliardi di lire per i soli ammortizzatosi sociali usati dal gruppo Fiat negli anni a cavallo tra Novanta e Duemila. Più 700 miliardi pubblici spesi per le migliaia di prepensionamenti nel gruppo decisi nel 1994, e altri 300 miliardi per le migliaia messi in mobilità. Fino all’ultima ondata di maxi incentivi pubblici agli acquisti di nuove auto: l’ultima grande legge in materia, del 1997, costò allo Stato 2100 miliardi di lire, di cui 800 beneficiarono la Fiat, che allora vantava ancora il 40% del totale del mercato auto domestico.
Questa è storia, non la può cambiare nessuno. Una storia che s’interruppe negli anni Duemila, e che facendo venir meno la stampella di Stato portò rapidamente gli errori dei mancati investimenti Fiat alla soglia del baratro, quando nel 2004 tutto cambiò con Marchionne. Sulla base di questi numeri, molti ritengono che l’Italia abbia più creduto nella Fiat, di quanto la Fiat stessa abbia creduto nell’Italia. Tuttavia è una storia che abbiamo alle spalle: fitta di errori tanto dell’azienda torinese, che della politica italiana. Che ha sempre creduto, coprendo l’azienda di aiuti, se ne potesse alla fine condizionare gestione e futuro. Ci pensò Enrico Cuccia, alcune volte anche mettendo la famiglia Agnelli in minoranza nel comitato strategico della Fiat, a impedire che ciò avvenisse. Ora che a tutti gli effetti Fca è non solo un gruppo internazionalizzato, ma ha alla testa un britannico, è bene che la politica si dia una regolata. Meglio tardi che mai, visto che era necessaria da lungo tempo.
Il primo principio è che il governo dovrebbe entrare nell’ordine di idee adottato da tutti i maggiori Paesi europei e occidentali che nei decenni hanno aperto a insediamenti produttivi diretti di produttori stranieri: la produzione di auto e veicoli industriali dovunque è un settore strategico per la manifattura e gli occupati, e dunque i governi si attivano per farsi illustrare in dettaglio i piani industriali dei gruppi, gli occupati e gli investimenti previsti. Con la Fiat da noi non è avvenuto per decenni. Ma avviene in Germania, in Francia, nel Regno Unito, in Spagna. Non si tratta di esercitare improprie inframmettenze politiche nelle decisioni d’impresa: ma essere parti attive per considerare insieme quali condizioni possano rafforzare e non indebolire la produzione diretta in ciascun Paese. Con Fca di fatto del tutto internazionalizzata, occorrerà essere più proattivi di quanto non sia capitato in una lunga storia italiana che credeva di ottenerne riconoscenza con aiuti diretti.
Secondo, difendere la produzione di auto in Italia è fondamentale non solo per gli oltre 30mila dipendenti Fiat, e perché la produzione in Italia grazie a Marchionne è stata non solo difesa ma tecnologicamente innovata e ha fruttato per l’intero settore degli autoveicoli un export che nel 2017 è ammontato a 26 miliardi di euro, rispetto a 33 circa di importazioni. Il punto è che la produzione italiana di auto è il pilastro della crescita nella parte alta delle catene del valore dell’intera filiera della componentistica e dell’automotive italiana: che nel 2017 è valsa un export di 21,6 miliardi con un saldo attivo commerciale superiore a 5 miliardi, ed eccellenze mondiali che concorrono a fornire il settore premium dei maggiori gruppi mondiali. La politica si abitui a considerare l’intera filiera automotive come strategica: occupa 160 mila addetti diretti e 93 mila indiretti, pari al 7% degli occupati dell’intera industria manifatturiera italiana. Coin un fatturato complessivo 2017 pari a 93 miliardi di euro, cioè il 5,6% del PIL a prezzi correnti, e il 18,8% della spesa in ricerca e sviluppo della manifattura italiana.
Infine, terzo principio: è venuto il momento di aprire la porta in Italia anche a produttori di autoveicoli stranieri, internazionalizzati come Fca lo è diventata. Lo hanno fatto decenni fa Paesi come il Regno Unito e Spagna, l’hanno fatto anche gli Stati Uniti aprendo a giapponesi e asiatici. Noi no, e il bilancio amaro è che ne abbiamo pagato più prezzi che ottenerne vantaggi.




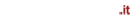














ACCEDI AL Il Mattino.it
oppure usa i dati del tuo account